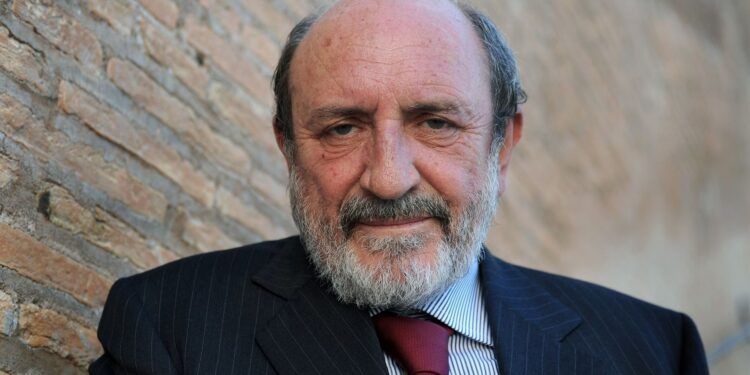La gravidanza indesiderata in adolescenza
L’adolescenza rappresenta una fase evolutiva importantissima per l’essere umano poiche’ comporta il passaggio dalla fase infantile a quella adulta. In tale periodo l’adolescente attraversa una serie di cambiamenti a livello fisico (processi di maturazione biologica che conducono alla comparsa dei caratteri sessuali secondari ed alla fertilità), psicologico , affettivo e sociale arrivando ad una nuova sperimentazione di sé, ad una ridefinizione del rapporto col proprio corpo ed al consolidamento della propria identità di genere ; tutto cio’ si realizzza non senza attraversare momenti di disorientamento, isolamento, emozioni forti e contrastanti, incertezze sulla propria identità, su cosa si desidera e ciò che potrebbe piacere. In questa delicata fase di incertezza il gruppo dei pari diventa un vero e proprio gruppo di riferimento con cui confrontarsi ed all’interno del quale sperimentare la propria sessualità alloerotica, ovvero con un’altra persona. L’innamoramento è solitamente vissuto come totalizzante e spesso ad esso seguono le prime esperienze sessuali, che possono essere vissute in modo differente, assumendo svariati significati e funzioni. Da quanto emerso dagli studi effettuati, il primo rapporto solitamente avviene tra i 15 e i 16 anni e , nonostante le campagne informative e di responsabilizzazione relative all’utilizzo di metodi contraccettivi, per evitare le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate , molti adolescenti ancora li rifiutano adducendo varie motivazioni (senso di fastidio che reca l’uso del preservativo , …la sensazione di onnipotenza adolescenziale che va di pari passo con la non percezione del rischio..ecc) ; spesso ricorrono al coito interrotto o ad altri metodi fallimentari (es. eiaculare in vagina durante il ciclo
mestruale ) e , grazie ai falsi miti, pensano che la coppia sia esente dal rischio di gravidanze indesiderate. Tutto cio’ non fa che facilitare tale esperienza che non comporta solo un cambiamento fisico, ma soprattutto un cambiamento identitario e sociale in un momento nel quale è ancora in corso il processo di definizione della propria identità femminile, rappresentando , cosi’ , un trauma poiche’ non si è pronti ad affrontare e gestire tale esperienza con consapevolezza e maturità. La formazione dell’identità materna si sovrappone bruscamente alla propria immagine di sé come donna- I sopraggiunti cambiamenti fisici indesiderati (nausee, cambiamenti corporei), le visite mediche alle quali sottoporsi , le situazioni psicologicamente stressanti, possono comportare depressione, disagi emotivi, sociali (abbandono della scuola, isolamento), di coppia (cosa decidere con il partner, il timore di essere abbandonata) e familiari(come dirlo ai genitori, timore della loro reazione e dei possibili cambiamenti nell’assetto familiare).La ragazza potrebbe vivere una condizione di frustrazione e sentirsi confusa, ansiosa, impreparata poiché ancora invischiata in conflitti di separazione ed individuazione dalle figure genitoriali. Pertanto, non essendo in grado di affrontare questa esperienza imprevista, potrebbe minimizzare o negare la realtà non rendendola nota immediatamente ai propri genitori. L’esperienza della gravidanza indesiderata spiazza sia l’adolescente sia i suoi genitori che si ritrovano a provare emozioni forti mentre devono gestire scelte importanti in gran fretta per non oltrepassare i limiti temporali per una eventuale interruzione volontaria della gravidanza. Quest’ultima esperienza comporta delle conseguenze a livello emotivo e psicologico rilevanti ( la cui intensita’ dipende dall’importanza attribuita alla maternita’ dalla ragazza) che è importante gestire ed elaborare con il sostegno emotivo dalle figure di riferimento principali (genitori e partner) . L’elaborazione del lutto e’ facilitata dalla esperienza di condivisione . Un lutto negato potrebbe determinare conseguenze a breve e lungo termine difficili da elaborare ; tra le conseguenze si potrebbero riscontrare : la sindrome post-abortiva ( solitudine e negazione dell’accaduto) , un congelamento delle emozioni, disturbi psicosomatici , problemi nella sfera intima e sessuale, stress, depressione, ansia, insonnia, la riattivazione del dolore rimosso in presenza di eventi stressanti, l’incrinarsi dei legami familiari, l’incapacità a gestire l’idea di una nuova maternità. Il sostegno emotivo e psicologico, la condivisione empatica dell’esperienza, sono essenziali per permettere all’adolescente di proseguire il percorso di crescita e di formazione della propria identità . Si sottolinea , inoltre , la necessita’ di avviare periodici e costanti interventi di prevenzione che si occupino di educazione psico-socio-affettiva , che facilitino scelte consapevoli , comportamenti responsabili oltre che un adeguato sviluppo psico sessuale